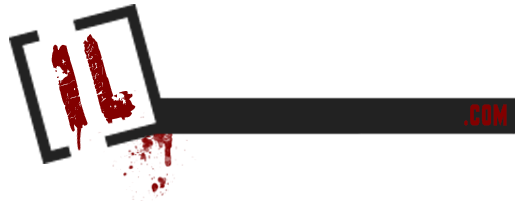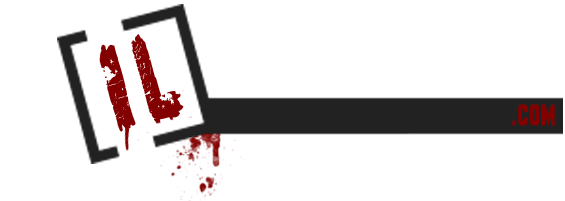Il Seppuku, il suicidio rituale
Se la maggior parte delle leggende occidentali vanno indietro di 3 o 4 secoli, quelle orientali hanno radici molto più antiche e certe pratiche moderne hanno mantenuto quasi le stesse modalità del passato, a differenza delle nostre che nel tempo si sono modificate e spesso hanno cambiato di scopo.
La cultura giapponese, in particolare, tramanda ancora tradizioni vecchie di millenni, alcune delle quali nemmeno contemplate da noi occidentali. Una di queste tradizioni è il seppuku, che fuori dal Giappone è conosciuto anche come “harakiri”
“Seppuku” letteralmente significa “taglio dello stomaco” ed è una pratica di suicidio rituale dalle origini talmente antiche da perdersi nei secoli. Noi conosciamo tale pratica grazie al cinema, che in molti film ambientati nel Sol Levante vediamo il solito ricco orientale che per la vergogna si toglie la vita conficcandosi una spada in pancia. In realtà si tratta di un rituale complesso e con un grande significato.
Come ho scritto, le origini sono andate perdute, ma uno dei primi racconti sulla pratica del seppuku è datato anno 1170: in una delle molte battaglie tra clan il leggendario samurai Minamoto No Tametomo affrontò il clan Taira; le sua abilità con l’arco erano ineguagliabili e si dice che abbia addirittura affondato un’intera nave Taira con le sue frecce; tuttavia i nemici erano molti a uno di loro riuscì a colpirlo ad un braccio recidendogli i tendini. Conscio di non poter più combattere, preferì piantarsi un coltello nell’addome piuttosto che cadere nelle ani dei nemici.
Il primo caso storicamente documentato è di poco tempo dopo, il 1180. Sempre nel periodo degli scontri tra i Minamoto e i Taira, uno dei più grandi combattenti della casata, Minamoto No Yorimasa preferì togliersi la vita all’umiliazione della sconfitta e così scrisse un poema di morte prima di pugnalarsi all’addome e suicidarsi.
«Come un vecchio albero
da cui non si raccolgono i fiori
triste è stata la mia vita
destinata a non portare alcun frutto.»
Il rituale del seppuku poteva essere spontaneo o indotto: quello spontaneo era volto ad espiare colpe o inadempienze verso il proprio maestro, la famiglia o il proprio popolo; quello indotto era considerato un privilegio e veniva concesso solo a persone che pur macchiandosi di gravi colpe avevano una carica importante o avevano servito in maniera integerrima fino ai loro crimini.
Sebbene da noi in Occidente il cristianesimo veda il suicidio come un atto con Dio che ci concede la vita (in passato veniva punito negando al suicida perfino di essere seppellito in luogo sacro e indurlo non era nemmeno pensabile), in Giappone era perfino ammirato perché era una pratica che dimostrava la libertà di un soggetto di decidere di morire: il seppuku era il più grande onore che si potesse concedere ad un nemico sconfitto o ad un condannato a morte.
Il rituale era volto a “liberare l’anima” del peccatore, che si credeva risiedere nel ventre: per questo motivo ci si poneva nella posizione “seiza” (in ginocchio con il busto leggermente spostato in avanti cosicchè alla morte il corpo sarebbe caduto in avanti) e ci si trafiggeva con un “tantô”, un pugnale sacrificale appositamente preparato con una lama incredibilmente affilata. Il taglio dello stomaco doveva avvenire secondo una precisa linea, prima da sinistra verso destra e successivamente verso l’alto: se tutto veniva eseguito nella maniera giusta il suicida se ne andava nel modo più onorevole possibile.
Quando il suicidio veniva indotto, come ad esempio in seguito ad una condanna a morte o per pietà da parte di un nemico, si concedeva al condannato un compagno come assistente, detto “kaishakunin” (che letteralmente significa “decapitatore”), la cui funzione era quella di attendere il taglio dell’addome del suicida per poi tagliargli la giugulare in modo da evitare una lunga agonia. Anche il kaishakunin doveva eseguire il taglio in maniera esemplare e soprattutto precisa perché doveva uccidere istantaneamente il suicida senza staccargli completamente la testa: perdere la testa per un samurai significava infatti portare disonore e disgrazia a lui e ai suoi discendenti.
Anche alle donne era permesso il rito del suicidio, che però in questo caso veniva chiamato “jigai”. La differenza stava nel taglio che doveva praticarsi la suicida: ella non si pugnalava la ventre, bensì praticava un taglio della giugulare e doveva compierlo senza alcun tipo di assistenza. lei doveva mantenere una posa onorevole e per questo motivo la donna legava assieme le ginocchia in modo da cadere rannicchiata in avanti.
Per le donne più che per disonore si trattava di un suicidio preventivo e lo scopo era spesso quello di evitare lo stupro in seguito alla morte in battaglia da parte del proprio marito.
Oggi possiamo dire che il rituale del seppuku è praticamente stato abbandonato, ma i giapponesi ricordano bene ciò che successe il 25 novembre del 1970, quando lo scrittore Yukio Mishima, dopo aver occupato il palazzo del Ministero della Difesa, inneggiò ai veri valori nipponici a alle tradizioni perdute, per poi tentare il seppuku di fronte a decine di persone.
Il rituale tuttavia non andò come previsto perché dopo essersi conficcato il pugnale nell’addome, il suo discepolo Masakatsu Morita fallì per ben due volte nel taglio della testa e prolungò l’agonia di Mishima. Dovette intervenire un altro discepolo di nome Hiroyasu Koga a porre fine alla vita del suo maestro e dovette ripetersi quando poco dopo lo stesso Morita sentì il dovere di togliersi la vita in quanto incapace di sopportare il senso di colpa nell’aver deluso il suo maestro.